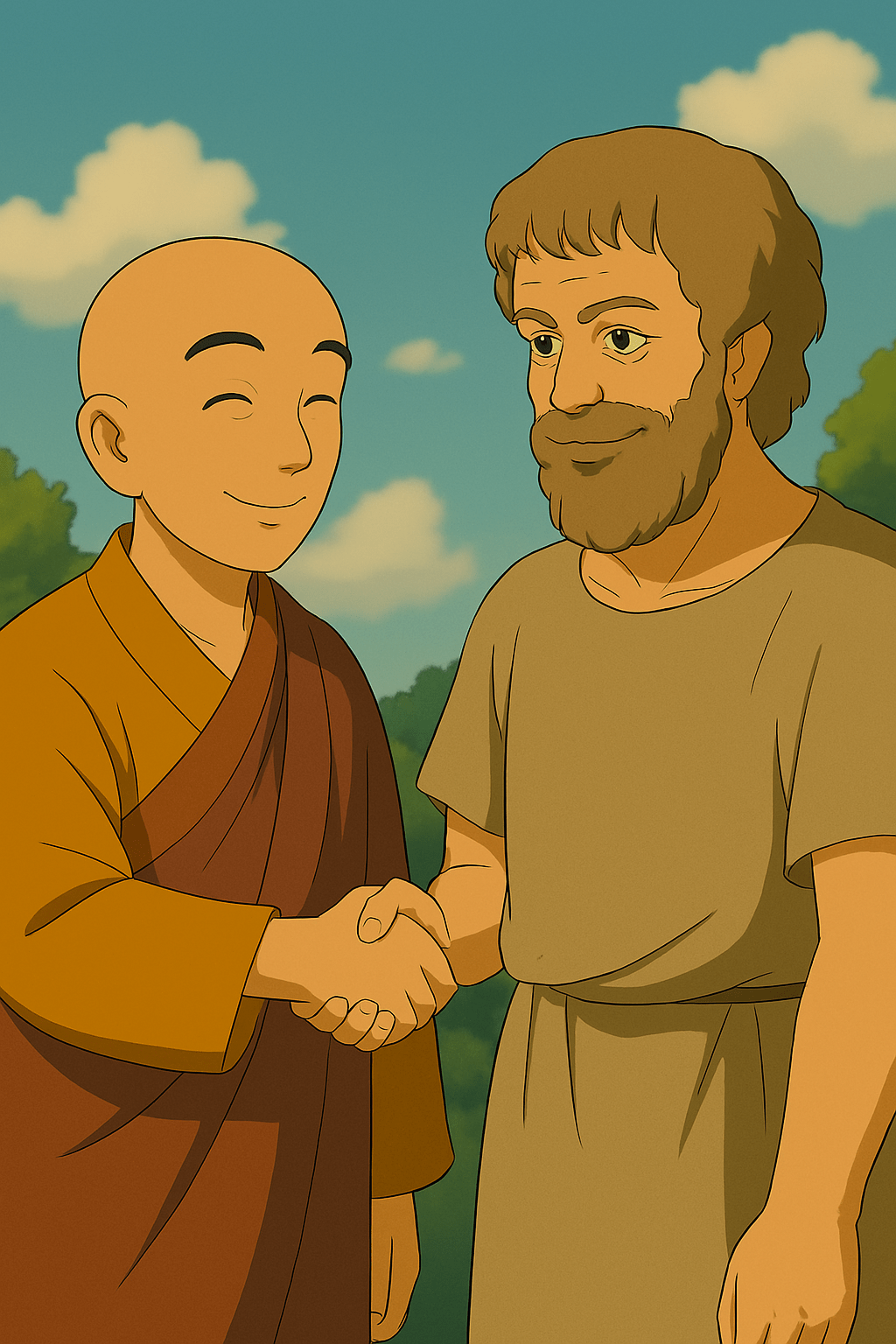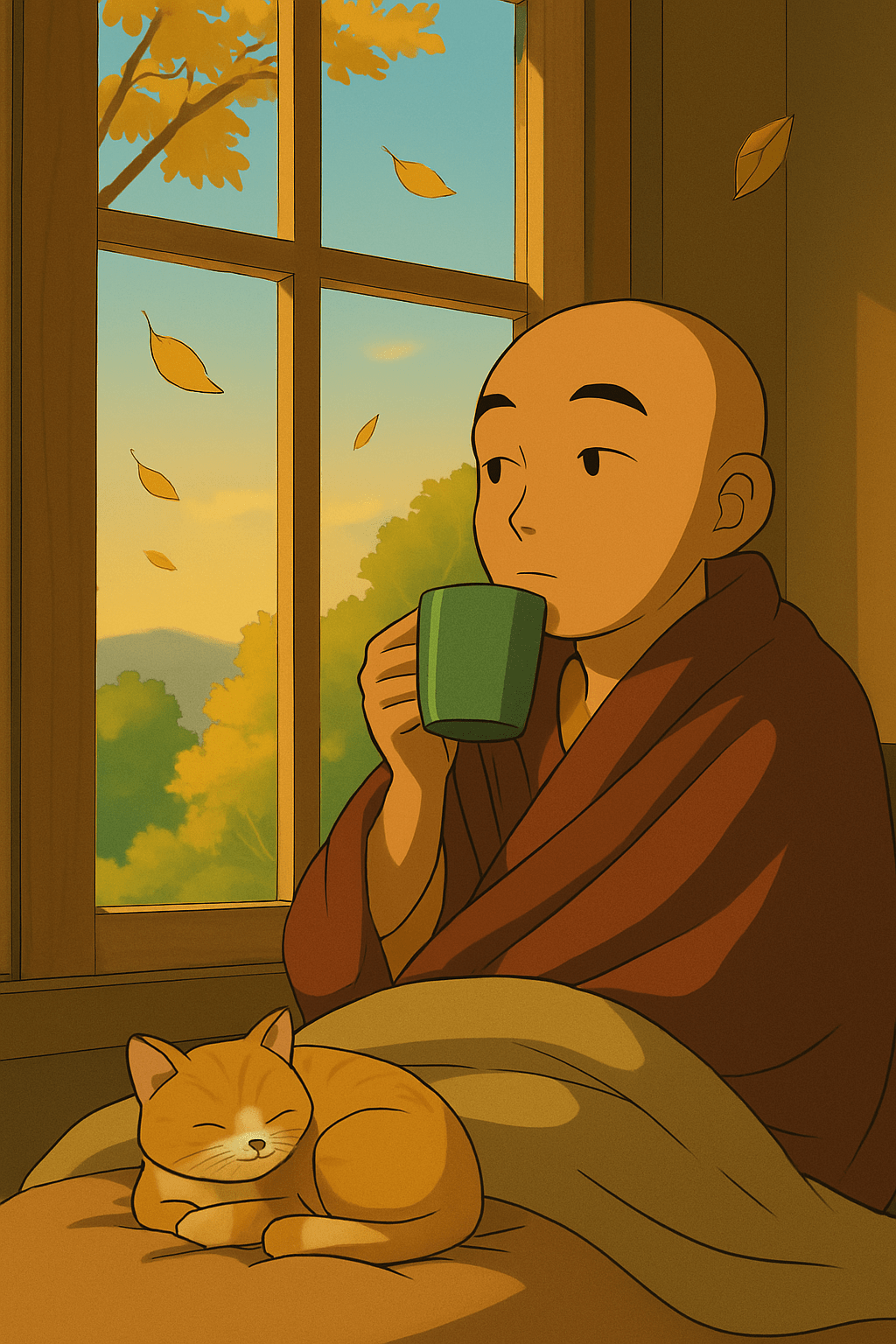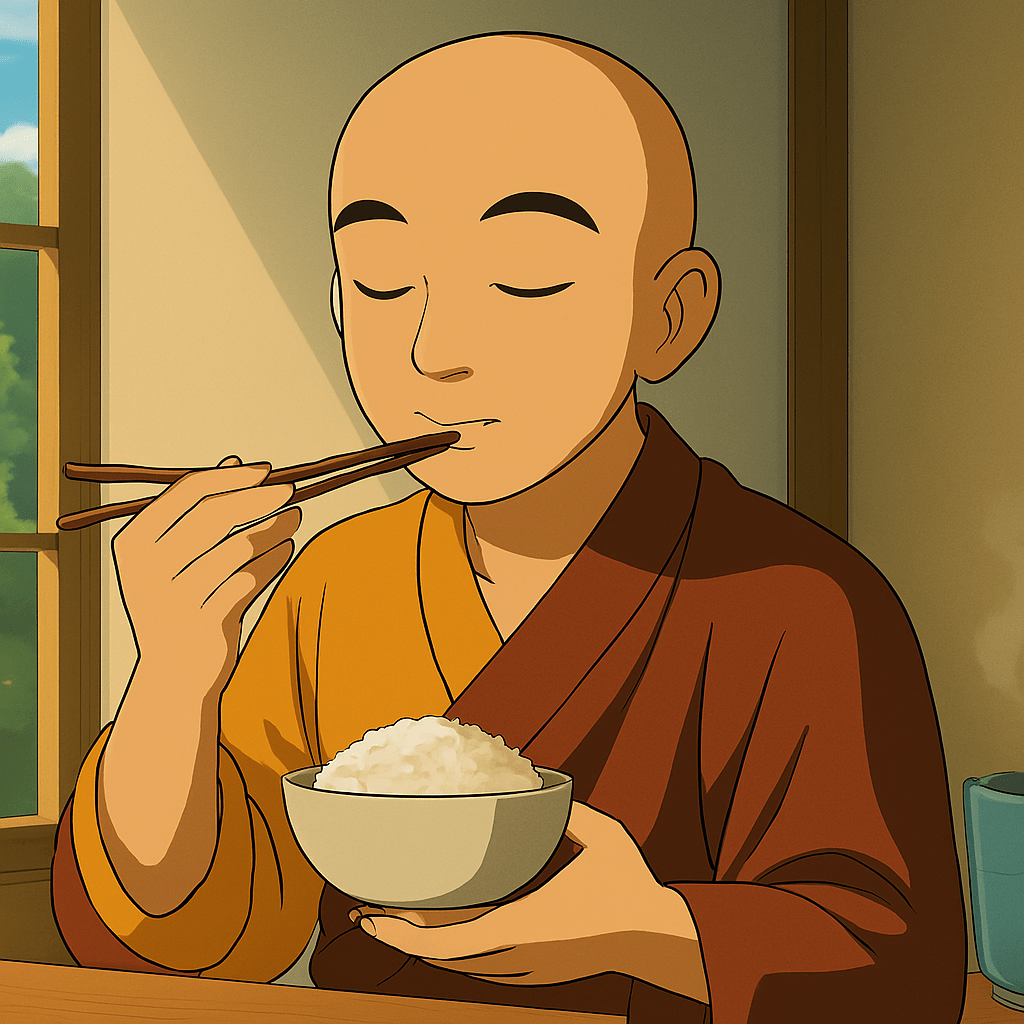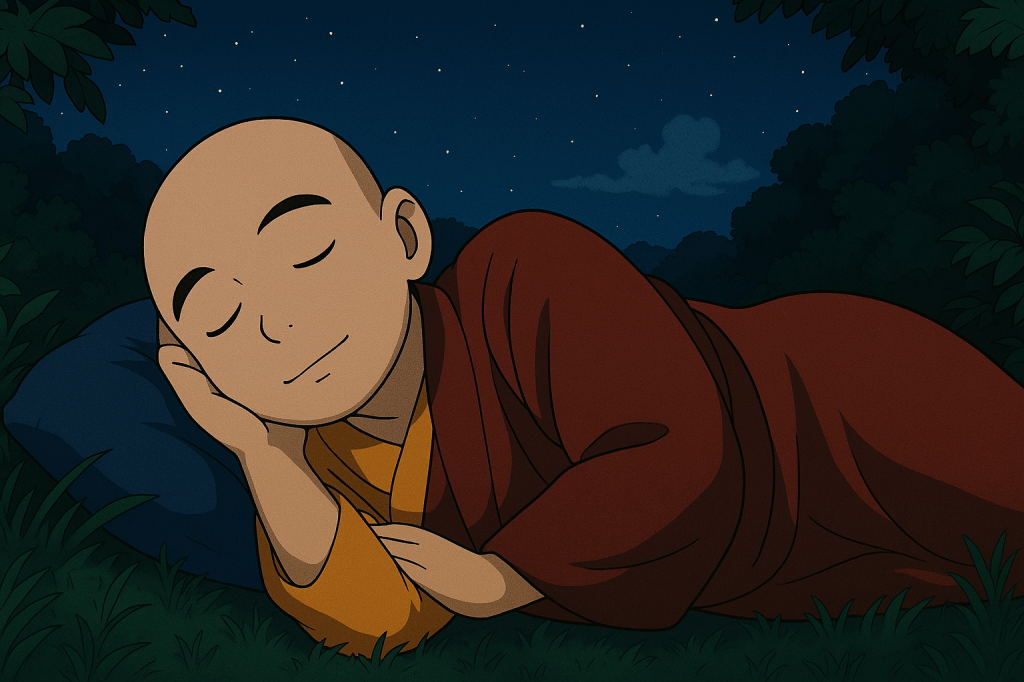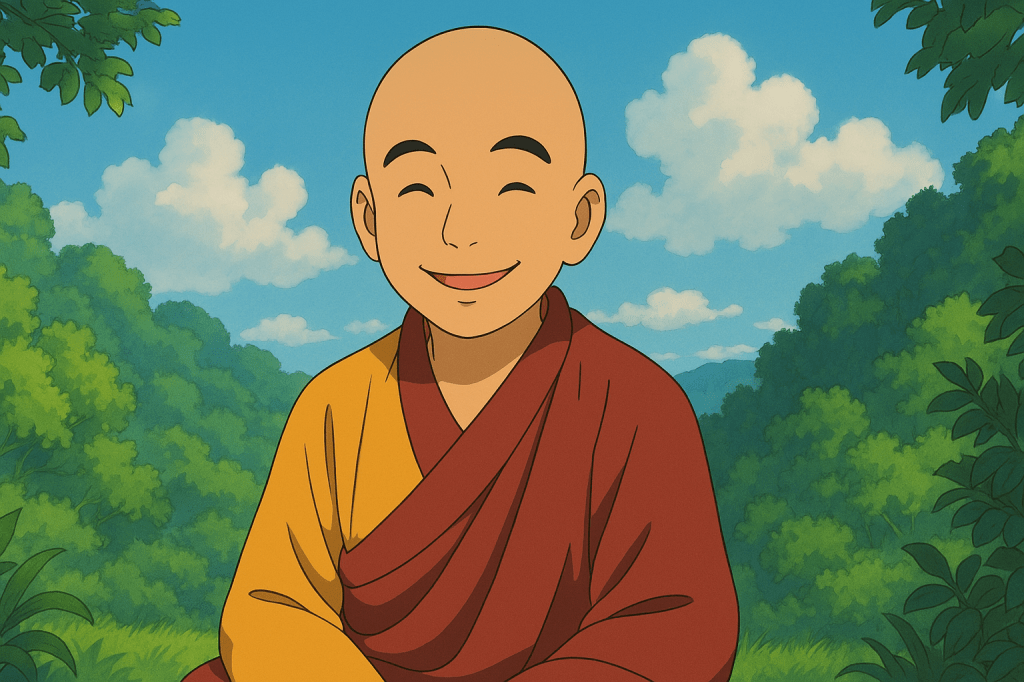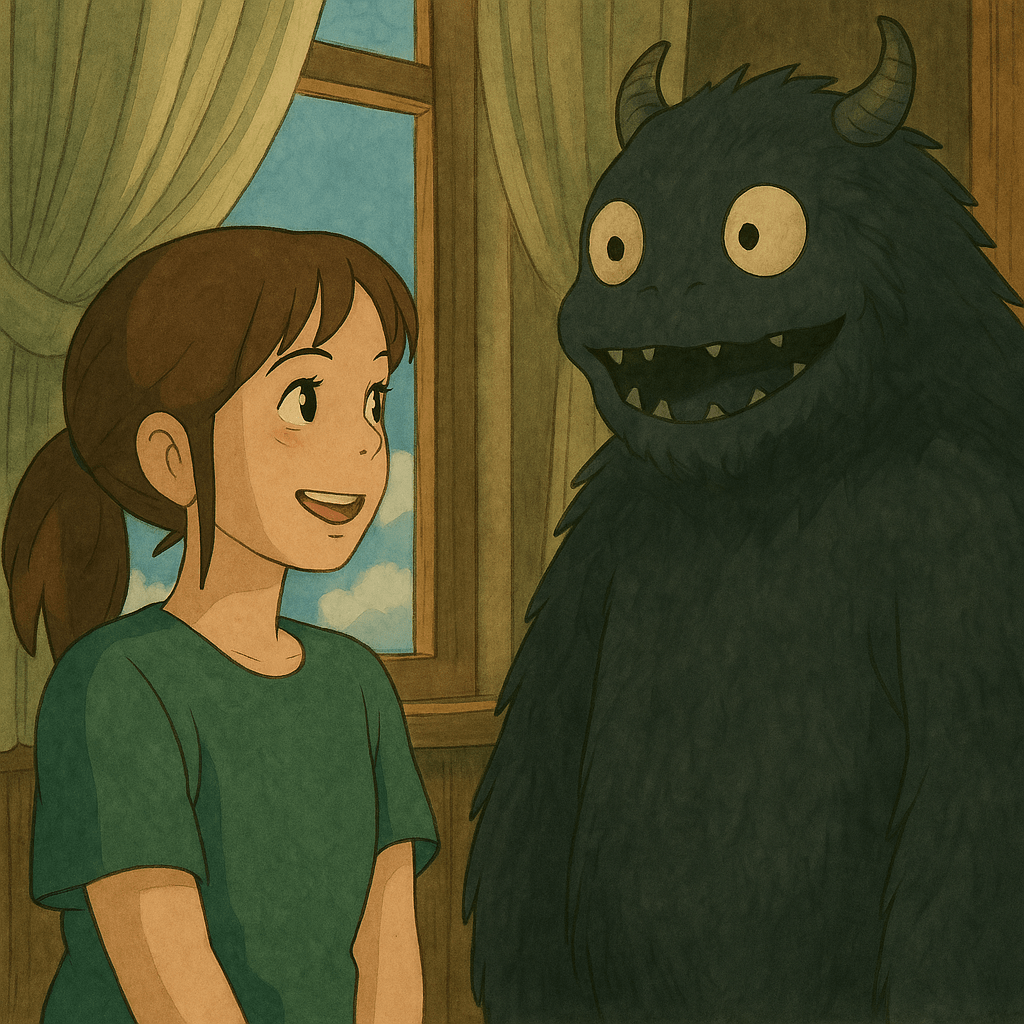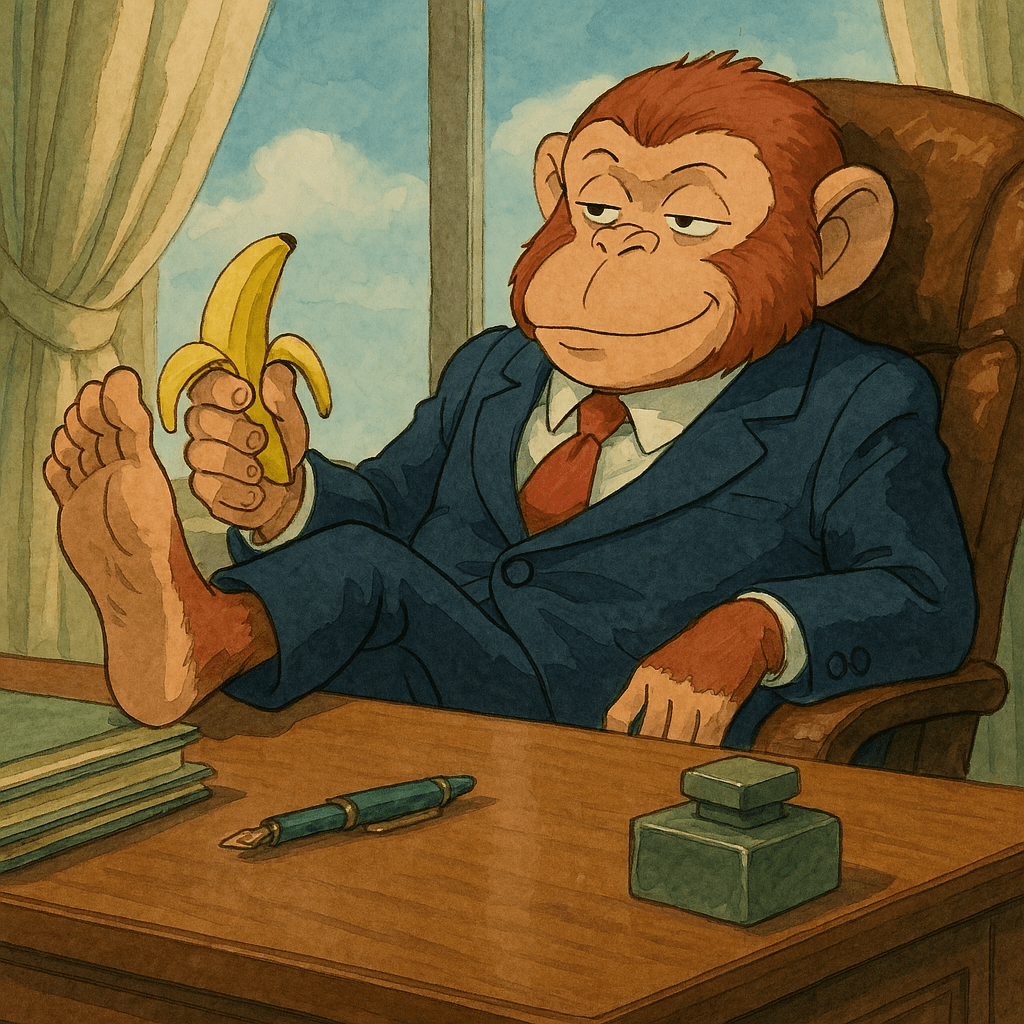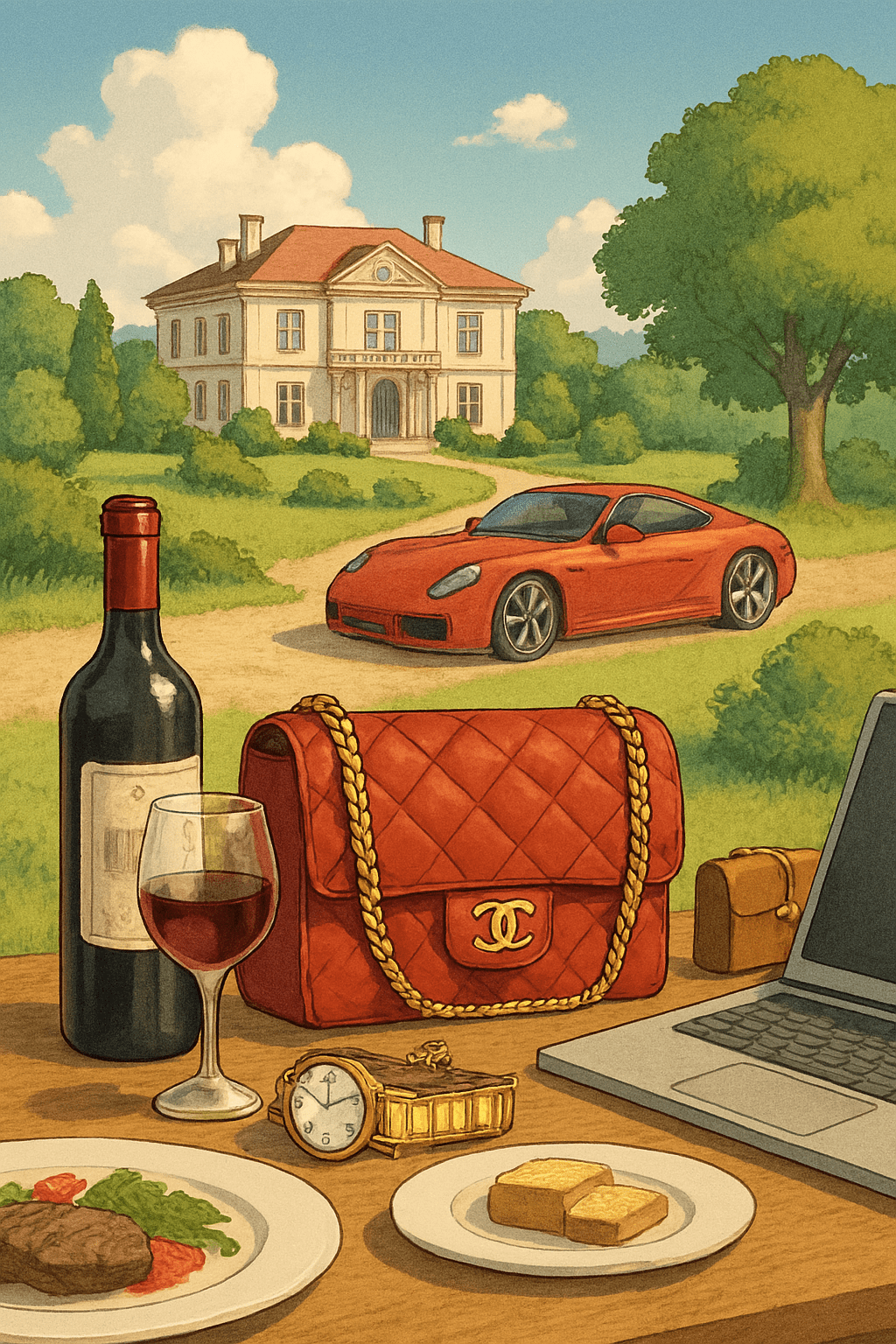Quando si pensa al buddhismo, si immagina spesso una religione fatta di templi, statue e meditazione. Ma il buddhismo è anche — e forse prima di tutto — una filosofia pratica dell’esistenza, un insegnamento radicale che invita a guardare in faccia la sofferenza, la transitorietà delle cose e l’illusione del sé. In questa esplorazione, ci lasciamo guidare dalle parole del prof. Giangiorgio Pasqualotto, esperto di filosofia orientale all’Università di Padova.
Un ciclo di insegnamenti per ritrovare lucidità Il buddhismo può essere compreso attraverso pochi concetti essenziali, radunati nel Dhammapada, un piccolo libro che raccoglie e distilla gli insegnamenti del Buddha in una lingua accessibile e concreta. In questo articolo approfondiamo i primi tre pilastri di questo pensiero: Dukkha (il dolore), Anicca (l’impermanenza) e Anattā (la non-esistenza del sé indipendente).
Dukkha – Il dolore come porta d’accesso Il Buddha parte da un’osservazione semplice quanto sconvolgente: esistere comporta dolore. Il dolore non è una condanna assoluta, ma una condizione potenziale presente in ogni esperienza. La sua causa è taṇhā, la brama: desiderio ardente accompagnato da attaccamento verso ciò che non può durare. La via d’uscita sta nella consunzione della brama, simile alla cera che si consuma in una candela. Il processo si chiama nirodha (estinzione temporanea) e conduce al nirvana, mentre la pratica si articola nell’Ottuplice Sentiero — un insieme di strumenti etici, meditativi e cognitivi.
Il dolore psicologico come campo di pratica Oltre al dolore fisico, il Buddha riconosce come centrale il dolore mentale, che nasce da:
- essere vicini a ciò che si detesta,
- o lontani da ciò che si ama.
Questi dolori hanno origine nell’atteggiamento mentale con cui leggiamo la realtà: nel nostro attaccamento all’idea che le cose durino.
Anicca – Niente è per sempre Tutto cambia. Tutto finisce. Nulla è eterno: né gli oggetti, né le persone, né le dottrine. Lo stesso Buddha rifiuta di pronunciarsi sull’eternità dell’anima o dell’universo. Come Kant, riconosce i limiti della ragione e invita a rivolgerci all’esperienza diretta. Persino il Dharma — il suo stesso insegnamento — è impermanente e destinato a trasformarsi. Non ci si deve attaccare a nulla, nemmeno al buddhismo.
Anattā – Il sé come illusione relazionale Se tutto è impermanente, anche il sé non può essere qualcosa di fisso. La nostra identità è un flusso mutevole, fatto di relazioni e condizioni che cambiano. Attaccarsi a un’idea fissa di sé, come a un ruolo o a un’etichetta, è fonte di dolore — perché nulla di ciò che chiamiamo “io” è permanente.
Conclusione – L’impermanenza come chiave di libertà Il buddhismo non invita a fuggire dalla realtà, ma a viverla con consapevolezza e leggerezza. Accettare che tutto cambia ci permette di amare senza possedere, vivere senza paura e lasciar andare senza rimpianto.